Tregua
FRATELLI D'ITALIA ...
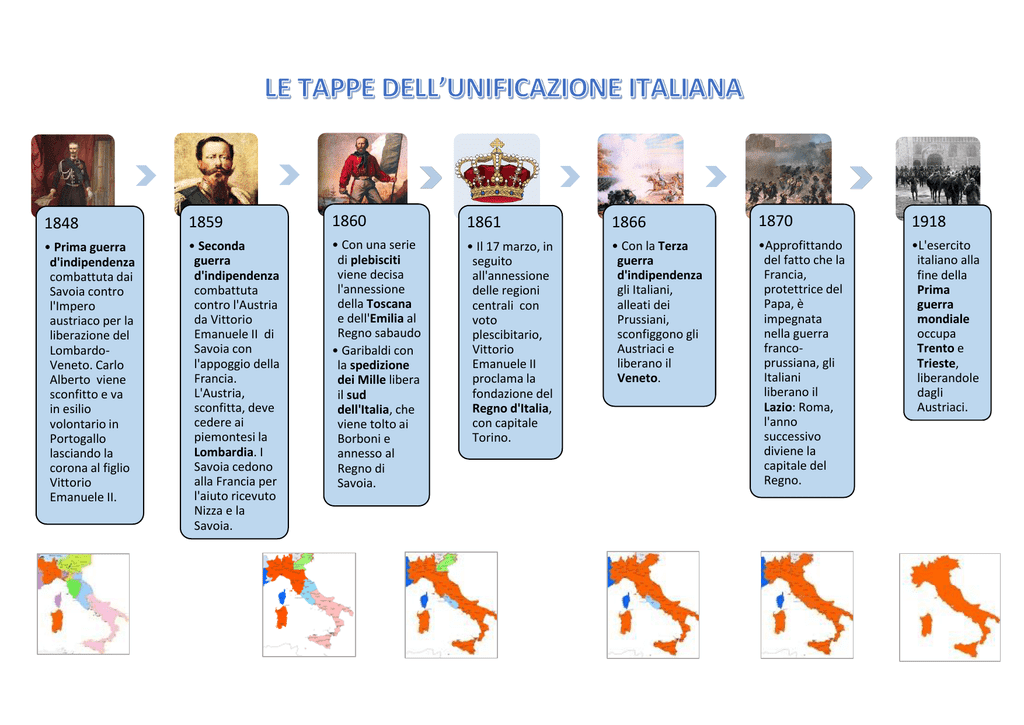
... PROSEGUIAMO DOPO L'ESTATE
Riflessioni, tra ieri e oggi
Noi ridiamo, oggi, quando sentiamo parlare della Padania, e i più ridevano anche quel 15 settembre del 1996, quando il partito politico della Lega - allora Lega Lombarda - ne proclamò la nascita. Però - per dire - prendiamo sul serio il popolo dei Franchi: lo abbiamo consacrato nei libri, lo studiamo e giudichiamo le sue vicende come una parte rilevante della storia europea. E sì che i Franchi non sono altro che dei Padani di maggior successo. Né gli uni né gli altri avevano alle spalle una storia, una tradizione, un vissuto comune che ne legittimasse un'identità propria. Entrambi sono sorti nello spazio di un mattino, rispetto alle unità temporali della Storia, solo che i Franchi sono riusciti ad affermarsi e i Padani no.
La nazione non è un dato di natura. Manchiamo clamorosamente il bersaglio, se codifichiamo la nazione con gli elementi esteriori - lingua, geografia, religione, e via così - che accomunano un popolo. Questi elementi sono un coadiuvante, non il principio attivo.
La nazione non è un dato di natura. Manchiamo clamorosamente il bersaglio, se codifichiamo la nazione con gli elementi esteriori - lingua, geografia, religione, e via così - che accomunano un popolo. Questi elementi sono un coadiuvante, non il principio attivo.
Una comunità può sentirsi nazione per i motivi più disparati, e i valori alla base dell'identità nazionale cambiano nel tempo e nello spazio. La Svizzera è una nazione, anche se abitata da persone di lingue diverse. Gli Stati Uniti sono una nazione, anche se formati da svariate etnie. Ogni definizione formale di "nazione", se accostata alla realtà, rivela così tante smagliature, e impone così tante eccezioni, da far dubitare della sua effettiva capacità chiarificatrice.
L'unica definizione sensata sfiora la tautologia: si è una nazione perché si vuole esserlo. Con più esattezza e in modo meno banale: una comunità diventa nazione quando decide di percepirsi diversa dal resto del mondo, quando quella percezione è supportata da una strategia politica, quando il contesto storico permette di attuare e consolidare quella politica.
Ne abbiamo riscontri già in epoca greco-romana. "Tu sei la dimostrazione che essere greco o barbaro è una differenza dei corpi, non delle anime", scriveva un Arcivescovo a un Generale romano di origine barbarica, a testimoniare che la distanza stava solo nei luoghi d'origine e nell'aspetto fisico, ma poteva essere azzerata dalla volontà di aderire a un progetto politico e a un sistema di valori.
L'identità nazionale è sì intessuta di storia, ma il più delle volte è una storia costruita ad arte, inventata e infarcita di miti, basata sulla manipolazione di immagini ed eventi di ogni tipo, al solo scopo di creare e trasmettere un'elevata carica emotiva, di suscitare uno scatto d'orgoglio, un impeto strumentale a chi vuol riunire genti disperse. Chiedete pure ai Franchi, ma anche ai Longobardi e agli Alemanni, in tempi più recenti agli Zulù, e, sì, interpellate pure i Padani.
"L'Italia non fu come Inghilterra, Spagna e Francia perché Iddio la creò svariata, la fe' lunga e smilza, e rotta da' fiumi e da montagne; la popolò di stirpi diverse d'indoli, di bisogni, di costumanze" - scriveva Giacinto de' Sivo nel suo "I Napolitani al cospetto delle Nazioni Civili" - "Non si può per una nazionalità ideale, distruggere le nazionalità reali".
"L'Italia non fu come Inghilterra, Spagna e Francia perché Iddio la creò svariata, la fe' lunga e smilza, e rotta da' fiumi e da montagne; la popolò di stirpi diverse d'indoli, di bisogni, di costumanze" - scriveva Giacinto de' Sivo nel suo "I Napolitani al cospetto delle Nazioni Civili" - "Non si può per una nazionalità ideale, distruggere le nazionalità reali".
Giacinto de' Sivo sbagliava.
Una terra "svariata [...] lunga e smilza, e rotta da' fiumi e da montagne", popolata da "stirpi diverse d'indoli, di bisogni, di costumanze", è solo una parte della storia di una nazione e non necessariamente la più rilevante. La prepotente retorica ottocentesca sovrascrisse quei pur oggettivi dati di fatto, e le (presunte) "nazionalità reali" furono piallate dalla (cosiddetta) "nazionalità ideale".
Perché la formazione di una nazione non passa solo da obiettive caratteristiche tangibili, ma anche - e forse soprattutto - dalla ferma volontà di sentirsi nazione, superando, se occorre, qualsiasi barriera "fisica". Massimo d'Azeglio coglieva il punto sia quando affermava con fine propositivo "fatta l'Italia, dobbiamo fare gli Italiani" - perché l'Italia avrà pure una sua geografia ben definita, ma l'italianità è uno stato dell'animo da suscitare, educare e difendere - sia quando domandava, con piglio critico, "a chi non ci vuole, con quale diritto possiamo rispondere colle fucilate?".
Viviamo oggi una fase confusa, caotica, di trapasso.
Politici e mass-media ci chiedono - baldanzosi - di sentirci europei. Ma se già la retorica nazionale ha perso mordente subito dopo la realizzazione del progetto unitario, se nessuno ci ha mai insegnato a essere italiani (con buona pace di d'Azeglio) e se c'è ancora chi si avvolge nella bandiera delle Due Sicilie e chi intitola scuole e vie a Re Ferdinando II di Borbone, come possiamo, oggi, in queste condizioni, sentirci parte di una costruzione incommensurabilmente più complessa e manifestamente più artificiosa?
"Voi, in Italia, i problemi li risolvete così" - ironizza Groucho, l'assistente di Dylan Dog - "inglobandoli in problemi più grandi".
Può accadere che il programma di un partito politico oltrepassi gli stereotipi - meno tasse, più lavoro, meno burocrazia, più sicurezza - per spingersi a offrire una nuova identità al proprio elettorato. Il programma della Lega (di Umberto Bossi) aveva esattamente questo obiettivo: noi siamo Padani e ci batteremo per il riconoscimento e l'indipendenza della Padania. Alberto da Giussano, il Carroccio, la Battaglia di Legnano - icone e battaglie del trapassato remoto, sconosciute ai più - riacquistarono improvvisamente attualità, divennero popolari, furono piegate all'obiettivo.
Il leggendario Alberto da Giussano,
l'icona del partito della Lega.
Può accadere che il programma di un partito politico oltrepassi gli stereotipi - meno tasse, più lavoro, meno burocrazia, più sicurezza - per spingersi a offrire una nuova identità al proprio elettorato. Il programma della Lega (di Umberto Bossi) aveva esattamente questo obiettivo: noi siamo Padani e ci batteremo per il riconoscimento e l'indipendenza della Padania. Alberto da Giussano, il Carroccio, la Battaglia di Legnano - icone e battaglie del trapassato remoto, sconosciute ai più - riacquistarono improvvisamente attualità, divennero popolari, furono piegate all'obiettivo.
Possiamo pure sorridere di un uso politico della storia così sbarazzino, di un collegamento così disinvolto, chiaramente forzato, tra la Lega Lombarda, anno 1176, e la Lega di Bossi, anno 1992. Ma la stessa operazione l'avevano già fatta i Franchi, e a loro era riuscita.
I Franchi realizzarono la necessità di avere un passato, per costruire e cesellare un'identità nel presente, e si misero così a scrivere del loro passato, diciamo pure a inventare la loro storia.
Noi veniamo da Troia. Tutti sapete di Enea, che fugge da Troia, sbarca nel Lazio e incontra i Romani. Ebbene, insieme a Enea c'era pure un principe troiano, Francione, anche lui fuggito da Troia... e, insomma, noi valiamo quanto voi, la nostra stirpe è antica come la vostra.
I Goti - gli Ostrogoti di Teodorico, in Italia - furono più raffinati. Condussero l'operazione in collaborazione con gli stessi Romani, gli unici a sapere come sviluppare una narrazione credibile e convincente. Affidarono all'intellettuale romano Cassiodoro il compito di scrivere la Storia dei Goti, e Cassiodoro ci si mise d'impegno a scriverla, a inventarla, per dimostrare che anche i Goti avevano un passato glorioso e illustre come i Romani. E il Re ostrogoto, nell'elogiare Cassiodoro in Senato, trovò naturale collocare quella storia - inventata - nel canovaccio della storia - autentica - di Roma: perché evidentemente c'era un solo quadro possibile - Roma - e serviva stare là dentro, se si voleva esistere come popolo e avere un'identità.
Questo fenomeno - per cui un popolo nasce all'improvviso col favore delle circostanze, e poi si inventa un nome e un'identità, e a quell'identità ci crede, sino a giocare un ruolo decisivo nella storia, pur non essendo mai esistito prima - è una ricorrenza che avvicina passato e presente.
Prendiamo gli Unni. Dove sono finiti? Gli Unni sono popolo sorto all'epoca delle invasioni barbariche, intorno a capi di grande carisma, per aggregazione sequenziale di svariate tribù. Al principio erano bande di pastori nomadi asiatici, ma poi, via via che avanzavano, altri si univano, germani, goti, chiaramente senza occhi a mandorla, ma tutti con l'interesse a essere Unni. Parliamo quindi di un'identità creata dalla rapida coagulazione di popoli tra loro anche molto diversi (lo stesso nome Attila - il più famoso Re unno - è un nome goto).
Questo fenomeno - per cui un popolo nasce all'improvviso col favore delle circostanze, e poi si inventa un nome e un'identità, e a quell'identità ci crede, sino a giocare un ruolo decisivo nella storia, pur non essendo mai esistito prima - è una ricorrenza che avvicina passato e presente.
Prendiamo gli Unni. Dove sono finiti? Gli Unni sono popolo sorto all'epoca delle invasioni barbariche, intorno a capi di grande carisma, per aggregazione sequenziale di svariate tribù. Al principio erano bande di pastori nomadi asiatici, ma poi, via via che avanzavano, altri si univano, germani, goti, chiaramente senza occhi a mandorla, ma tutti con l'interesse a essere Unni. Parliamo quindi di un'identità creata dalla rapida coagulazione di popoli tra loro anche molto diversi (lo stesso nome Attila - il più famoso Re unno - è un nome goto).
E si intravedono allora anche le ragioni per cui questi popoli spariscono. Quando l'espansione finisce, quando i capi-popolo perdono di ascendente, prestigio e autorità, quando altre figure prendono il sopravvento, un popolo costruito in questo modo può benissimo disgregarsi. Semplicemente non conviene più a nessuno dire "io sono Unno". Ci sono altre identità da scegliere, per avere successo. Gli Unni spariscono, non già perché siano stati sterminati in chissà quale tremenda battaglia, ma semplicemente perché il loro progetto politico è abortito.
Sostituite "Padani" a "Unni", cambiate quel poco che rimane da cambiare, e avrete esattamente la storia della Lega Lombarda di Umberto Bossi.
Il fatto che un'identità nazionale possa sorgere dal nulla, o esser risvegliata dal richiamo a eventi vecchi di secoli, non è ovviamente di per sé garanzia di successo dell'intrapresa. Devono esserci le condizioni al contorno - nel presente - affinché il tentativo abbia una buona riuscita. Nella seconda metà dell'Ottocento c'erano tutti i presupposti per concepire un'Italia unità, come oggi sono assenti tutte le condizioni per immaginare una penisola divisa.
Sostituite "Padani" a "Unni", cambiate quel poco che rimane da cambiare, e avrete esattamente la storia della Lega Lombarda di Umberto Bossi.
Il fatto che un'identità nazionale possa sorgere dal nulla, o esser risvegliata dal richiamo a eventi vecchi di secoli, non è ovviamente di per sé garanzia di successo dell'intrapresa. Devono esserci le condizioni al contorno - nel presente - affinché il tentativo abbia una buona riuscita. Nella seconda metà dell'Ottocento c'erano tutti i presupposti per concepire un'Italia unità, come oggi sono assenti tutte le condizioni per immaginare una penisola divisa.
Non irridiamo quindi i "Serenissimi", quel movimento che a metà degli anni '90 propagandò l'indipendenza, non solo del Veneto, ma della stessa Venezia, con azioni dimostrative anche eclatanti. Cosa dicevano, in fondo? Che la soppressione nel 1797 della Repubblica veneziana - a seguito dell'invasione napoleonica - fu un atto illegittimo, perciò da invalidare. Che il plebiscito del 1866 - per l'annessione del Veneto al Regno d'Italia - fu anch'esso privo di valore, perché viziato da accertate, gravi, irregolarità. Fatti storici incontrovertibili. Ma - nel loro presente - i "Serenissimi" non trovarono l'humus per radicare e sviluppare la propria visione delle cose.
Per sentirsi qualcosa - Romani, Franchi, Unni, Padani, Italiani, Europei, fate voi - serve una narrazione. Che sia vera o falsa, in tutto o in parte, è irrilevante. Non importa se determinati episodi, risalenti nei secoli, siano attualizzati e deformati alla bisogna. Conta solo - e il successo della Lega di Bossi lo conferma - che la storia riesca ad aprire una breccia nell'animo delle persone, che la gente la senta propria, che ci si riesca a identificare, e abbia magari anche più d'una convenienza a farlo.
Nessuno ci ha mai insegnato a essere italiani.
La narrazione della nazione italiana - con tutti i suoi eccessi - alla fine si è rivelata debole. Aver messo in sordina alcuni eventi del Risorgimento, sino a tacerli, e averne gonfiati altri, sino all'inverosimile, è stata una strategia perdente. Abbiamo esagerato col sale e le spezie, nell'ingenua speranza di realizzare un piatto piatto più saporito. Ne è invece venuta fuori una cosa immangiabile. Noi non possiamo dire - come altri popoli - "giusto o sbagliato, questo è il mio Paese". Perché non ci è mai stato insegnato cosa ci fosse di giusto e cosa di sbagliato nell'unità d'Italia, e perché le cose giuste superassero le sbagliate. Il nostro rapporto con la storia nazionale è piatto, monocorde, incolore, nonostante tutti gli orpelli, perché orfano di un elemento essenziale: il travaglio del parto.
Nessuno ci ha mai insegnato a essere italiani, figurarsi a essere europei. Come a dire: nessuno ci ha mai spiegato la semplice aritmetica elementare, figurarsi se poteva introdurci ai misteri dell'algebra superiore e alle alchimie dell'analisi infinitesimale.
Non è mai esistita una pubblicistica europea capace di coinvolgere, affascinare, persuadere e infine convincere. L'Europa - nella percezione dell'italiano medio - si associa a parole criptiche come "Troika", "rapporto debito-PIL", "procedura d'infrazione", "MES". Puri tecnicismi, incomprensibili, per di più dal suono suono sgradevole, ostile, minaccioso.
Gli stessi europeisti non riescono a definirsi e a qualificarsi, se non in opposizione ai cosiddetti sovranisti: non siamo sovranisti, quindi siamo europeisti. Definizione oscura - inafferrabile, scivolosa - come tutte le definizioni "al negativo", di contrapposizione.
Il parallelo è irriverente, ma rende l'idea. "Io sono romanista" ha un significato preciso: tifo per la squadra di calcio della Roma, la seguo e la sostengo, gioisco per le sue vittorie e soffro per le sue sconfitte. "Io non sono romanista" apre invece un ventaglio (indefinito) di possibilità: potrei essere juventino, interista milanista, ma anche tifare Akragas o Pergocrema, o potrebbe non importarmi nulla del calcio, oppure potrei semplicemente avere in odio la Roma, senza tifare per un'altra squadra. E ora immaginate che si dica: "Io non sono romanista, quindi sono...", e mi inventi dal nulla una parola - inesistente, assente nel vocabolario, ma con un suono ragionevole - che vada a sostituire i puntini di sospensione. Sarebbe un trucco, una manipolazione, un espediente retorico.
Questo è esattamente ciò che è avvenuto con l'Europa.
Questo è esattamente ciò che è avvenuto con l'Europa.
Perché - per confuso, incerto e malandato che sia - un sentimento di italianità sopravvive in ognuno di noi, e ognuno di noi tiene traccia del suo essere italiano, non fosse altro per il trascorrere del tempo che gioca a favore.
Tutti capiamo cosa voglia dire sovranismo: significa perseguire l'interesse politico, sociale e economico di una nazione chiamata "Italia", immediatamente percepibile al senso comune (e poco rileva, qui, se all'immediata percezione esterna non corrisponda poi uno spiccato senso di appartenenza all'interno).
Ma cosa vuol dire essere europeisti? Riusciamo a dare una definizione che non si riduca alla negazione di sovranista? Riusciamo a dire quali esperienze di condivisione nel passato, e quali sentimenti e interessi comuni nel presente, fondano il nostro essere europeisti? E riusciamo a dirlo con parole semplici, con linguaggio piano e accessibile ai più? O tutta questa mastodontica costruzione istituzionale, una volta scartavetrata dall'Euro, dal Patto di Stabilità, dal debito e dal PIL, si riduce al Premier olandese Mark Rutte che non vuol discutere con chi non capisce perché loro - gli olandesi - mettono sulla pizza delle fette d'ananas, quando noi italiani - "pensa che stronzi!", avrebbe detto Alberto Sordi - ci mettiamo sopra pomodoro e mozzarella?
La Prima Guerra Mondiale è uno spartiacque, nella storia d'Europa.
La Prima Guerra Mondiale è uno spartiacque, nella storia d'Europa.
La guerra - prima di allora - era sì un evento drammatico, ma rimaneva una possibilità concreta: la guerra poteva accadere, anzi sarebbe sicuramente accaduta, prima o poi, e bisognava trovarsi pronti all'eventualità. Tutto cambia, dopo quel che per noi italiani è il 1915-18 e per il resto d'Europa il 1914-18.
Dopo di allora, dopo la Prima Guerra Mondiale, l'intera classe politica europea ha una sola parola d'ordine: mai più - mai più la guerra, a nessun costo, o se si preferisce, la pace sempre, a ogni costo. E - per il più beffardo dei paradossi - la Seconda Guerra Mondiale scoppia proprio perché... non la si vuol fare accadere!
Hitler, salito al potere, si riprende con la forza ciò che ritiene essere di proprietà della Germania: prima l'Austria, poi la Cecoslovacchia. L'Europa lo osserva, lo lascia fare, in qualche circostanza lo aiuta pure. Sanno tutti di aver mortificato la Germania, di averla umiliata, di averle ingiustamente addossato l'intera colpa del conflitto del 1914-18. Hitler, in fondo, sta solo realizzando - con una certa irruenza - ciò che si sarebbe dovuto stabilire - equamente - per via diplomatica. Lasciamolo fare, ché a un certo punto si fermerà.
La storia della Seconda Guerra Mondiale è la storia di una doppia illusione: da un lato l'illusione dell'Europa democratica, di un Hitler che prima o poi avrebbe arrestato la sua marcia, già soddisfatto di quel che aveva riconquistato senza che nessuno lo ostacolasse; dall'altro l'illusione di Hitler, di poter proseguire nelle sue scorribande, nel silenzio generale, giacché anche solo una parola di contrasto avrebbe potuto innescare una nuova guerra che nessuno voleva.
L'Europa è frantumata, alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
L'idea di una identità europea è pura utopia, e la risposta all'utopia non poteva che provenire da visionari dotati di un vigile senso pratico, in una parola dai pragmatisti. L'armata pragmatista - leggiamo a pagina 37 della rivista "Leonardo", nel fascicolo del febbraio 1907 - accoglie due classi di menti: gli uomini pratici e gli utopisti. I primi perché trovano nel pragmatismo la teoria dei loro disprezzi per le questioni prive di senso e delle loro simpatie per tutto ciò che è chiaro, efficace e svelto. I secondi perché trovano nel pragmatismo le vedute suggestive che incoraggiano a sperare cose straordinarie.
L'Europa - come noi la conosciamo - è l'esito di un progetto pragmatista, utopico e pratico allo stesso tempo, ed è un esito straordinario. Viviamo una fase irreale, più di ottant'anni senza una guerra, nessun conflitto militare all'orizzonte, spese militari che pesano sempre meno nei bilanci degli Stati. E la cosa è tanto più straordinaria quanto più sembra ovvia, perché vuol dire trovare naturale il più utopico degli stati d'animo, lo stato di quiete, di pace.
Rimane però un equilibrio da qualificare.
La Prima Guerra Mondiale non fu la conseguenza dell'attentato di Sarajevo all'Arciduca Ferdinando, o meglio, quell'evento rappresentò solo la causa immediata, il pretesto. Le cause remote stavano altrove, e precisamente nel montare di un clima belligerante, in corpi politici e militari ormai da anni pronti alla guerra, e desiderosi di una guerra, certo non una guerra come quella che ne venne fuori, ma sicuramente ben predisposti verso un conflitto armato. Che ne è stato di quei sentimenti bellicosi? Sono realmente scomparsi o si sono semplicemente trasferiti altrove? Non esistono più o hanno solo cambiato forma? La pace sul fronte militare è un surplus netto o è pareggiata da tensione su altri fronti?
Cosa vediamo, se guardiamo l'Europa di oggi? Vediamo un'architettura istituzionale sottile nella dimensione sociale, debole nella strategia politica, dittatoriale in campo finanziario.
Sottile nella società, perché ogni nazione conserva ancora intatti tutti i suoi elementi "naturali", a iniziare dalla lingua e dai confini, perciò manca e mancherà sempre quell'amalgama esteriore che, pur non necessario, favorisce la percezione dell'identità.
Debole in politica, perché nessuno sa dire su cosa legiferi il Parlamento Europeo, se abbia o no il potere di mandare a casa la Commissione (o chi per essa) e perché nessuno sente di indirizzare davvero la politica dell'Europa attraverso il meccanismo del voto, delle elezioni.
Dittatoriale in finanza, perché la moneta è l'unico elemento tangibile di condivisione, perché i parametri europei sono tutti finanziari (e vantano la stessa cogenza delle leggi fisiche) e perché il whatever it takes di Draghi è diventato il manifesto dell'Unione.
L'Europa vive di tecnocrazia, e per di più di una tecnocrazia finanziaria, la più invisa all'opinione pubblica e al sentimento popolare, ammantata di pregiudizi atavici: il denaro sterco del demonio, nummus non parit nummus, e poi gli Gnomi di Zurigo, gli Spectre della City e i Signori dello Spread. Personaggi leggendari, a metà tra mito e storia, come Francione e Alberto da Giussano, su cui però non si può imbastire nessuna narrazione avvincente per giustificare l'Europa al senso comune, per avviare un percorso - comunque lungo e tortuoso - di creazione di una identità europea.
Cosa vediamo, se guardiamo l'Europa di oggi? Vediamo un'architettura istituzionale sottile nella dimensione sociale, debole nella strategia politica, dittatoriale in campo finanziario.
Sottile nella società, perché ogni nazione conserva ancora intatti tutti i suoi elementi "naturali", a iniziare dalla lingua e dai confini, perciò manca e mancherà sempre quell'amalgama esteriore che, pur non necessario, favorisce la percezione dell'identità.
Debole in politica, perché nessuno sa dire su cosa legiferi il Parlamento Europeo, se abbia o no il potere di mandare a casa la Commissione (o chi per essa) e perché nessuno sente di indirizzare davvero la politica dell'Europa attraverso il meccanismo del voto, delle elezioni.
Dittatoriale in finanza, perché la moneta è l'unico elemento tangibile di condivisione, perché i parametri europei sono tutti finanziari (e vantano la stessa cogenza delle leggi fisiche) e perché il whatever it takes di Draghi è diventato il manifesto dell'Unione.
L'Europa vive di tecnocrazia, e per di più di una tecnocrazia finanziaria, la più invisa all'opinione pubblica e al sentimento popolare, ammantata di pregiudizi atavici: il denaro sterco del demonio, nummus non parit nummus, e poi gli Gnomi di Zurigo, gli Spectre della City e i Signori dello Spread. Personaggi leggendari, a metà tra mito e storia, come Francione e Alberto da Giussano, su cui però non si può imbastire nessuna narrazione avvincente per giustificare l'Europa al senso comune, per avviare un percorso - comunque lungo e tortuoso - di creazione di una identità europea.
L'Euro - parole di Mario Draghi, all'epoca Presidente della Banca Centrale Europea - è "un mezzo per promuovere la pace tra le nazioni e anche un mezzo per migliorare la nostra prosperità collettiva".
La diagnosi dà conforto, ma il destinatario del messaggio - il cittadino europeo - continua a denunciare malessere, fastidi e intolleranze. A chi credere? Al referto del luminare della medicina o alla sensazione immediata del paziente in cura?
Torna in mente la barzelletta del primario in giro per le corsie dell'ospedale, con al seguito lo stuolo di specializzandi. Tasta il polso di un malato, gli misura la temperatura, e poi sentenzia: "Il paziente è morto". E tutti gli specializzandi a scrivere sulle loro cartelle: "paziente morto, paziente morto". Il primario passa oltre, e con lui lo sciame dei tirocinanti, quando l'ultimo di loro si sente tirare per il camice. "No, no... non... non sono morto!", sussurra il paziente di cui era stato decretato il sicuro decesso. Il tirocinante strattona bruscamente il camice, per liberarsi di quella pur debole presa, e con sguardo torvo e tono indispettito, rimette il malato al suo posto: "Zitto! Pensi forse di saperne più del Professore?".
L'Euro sarà pure "un mezzo per promuovere la pace tra le nazioni" e "per migliorare la nostra prosperità collettiva", ma non è un mezzo utile per sentirsi europei, per creare una identità europea. Pace e prosperità sono indubbiamente valori desiderabili, dal singolo e dalla collettività, ma rimangono condizioni appena necessarie, e di sicuro largamente insufficienti, per sentirsi uniti. Il mero benessere economico non ha mai affratellato genti diverse, non è mai stato di per sé un buon collante.
C'è di più. L'Euro sarà pur nato come "mezzo per promuovere la pace", ma poi, nel tempo, si è tramutato nell'oggetto su cui scaricare tutte quelle tensioni che una volta trovavano sfogo nei piani miliari e nei progetti di conquista territoriale. Tra l'800 e il '900 avevamo la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa, pronte a guerreggiare con bombe e fucili. Oggi abbiamo i Falchi e le Colombe, i Paesi frugali e i Paesi ad alto debito, in perenne, aspra, contrapposizione su vincoli di bilancio e capacità di spesa.
L'Europa non è un nuovo Impero Romano. Assomiglia piuttosto a un palloncino gonfio di elio. Noi abbiamo spostato il gas al suo interno, premendo su alcuni punti della superficie esterna. La pressione è diminuita in quei punti, ma è inevitabilmente aumenta in altri. Lo scoppio rimane sull'orizzonte delle possibilità.
Torna in mente la barzelletta del primario in giro per le corsie dell'ospedale, con al seguito lo stuolo di specializzandi. Tasta il polso di un malato, gli misura la temperatura, e poi sentenzia: "Il paziente è morto". E tutti gli specializzandi a scrivere sulle loro cartelle: "paziente morto, paziente morto". Il primario passa oltre, e con lui lo sciame dei tirocinanti, quando l'ultimo di loro si sente tirare per il camice. "No, no... non... non sono morto!", sussurra il paziente di cui era stato decretato il sicuro decesso. Il tirocinante strattona bruscamente il camice, per liberarsi di quella pur debole presa, e con sguardo torvo e tono indispettito, rimette il malato al suo posto: "Zitto! Pensi forse di saperne più del Professore?".
L'Euro sarà pure "un mezzo per promuovere la pace tra le nazioni" e "per migliorare la nostra prosperità collettiva", ma non è un mezzo utile per sentirsi europei, per creare una identità europea. Pace e prosperità sono indubbiamente valori desiderabili, dal singolo e dalla collettività, ma rimangono condizioni appena necessarie, e di sicuro largamente insufficienti, per sentirsi uniti. Il mero benessere economico non ha mai affratellato genti diverse, non è mai stato di per sé un buon collante.
C'è di più. L'Euro sarà pur nato come "mezzo per promuovere la pace", ma poi, nel tempo, si è tramutato nell'oggetto su cui scaricare tutte quelle tensioni che una volta trovavano sfogo nei piani miliari e nei progetti di conquista territoriale. Tra l'800 e il '900 avevamo la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa, pronte a guerreggiare con bombe e fucili. Oggi abbiamo i Falchi e le Colombe, i Paesi frugali e i Paesi ad alto debito, in perenne, aspra, contrapposizione su vincoli di bilancio e capacità di spesa.
L'Europa non è un nuovo Impero Romano. Assomiglia piuttosto a un palloncino gonfio di elio. Noi abbiamo spostato il gas al suo interno, premendo su alcuni punti della superficie esterna. La pressione è diminuita in quei punti, ma è inevitabilmente aumenta in altri. Lo scoppio rimane sull'orizzonte delle possibilità.

































Commenti
Posta un commento