BELLEZZA E CONOSCENZA - Epilogo: la bellezza come metodo
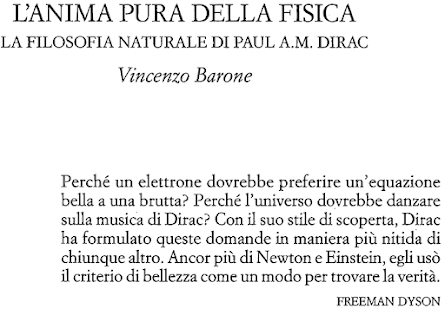
La posizione metodologica di Freemn Dyson - collocata dal Professor Barone a esergo della sua prefazione al volume "La bellezza come metodo", di Paul Dirac - suggerisce una perfetta sovrapposizione tra verità e bellezza, in forza della condivisione - tra le intelligenze evolute - del "criterio di bellezza per trovare la verità".
E c'è chi si è spinto oltre, affermando il primato della bellezza sulla verità. "Nelle
mie ricerche mi sforzai sempre di unire il vero al bello" - sosteneva il matematico e fisico Hermann Weyl, a quanto riferisce Dyson su una loro conversazione - "ma quando
dovetti scegliere fra l'uno e l'altro, di solito scelsi il bello".
D'altra parte, le nostre "Quattro Lezioni" ci hanno raccontato di straordinari successi conseguiti solo grazie a figure dalla spiccata sensibilità estetica: ciò che la loro immaginazione coglieva come bellezza doveva avere un valore di
verità, e trovare una manifestazione chiara, intellegibile.

La
matematica è fatica, e senza fatica non la si impara.
"Non esiste
nessuna strada regale che porta alla geometria" - rispose coraggiosamente
Euclide a Re Tolomeo, che gli domandava se non vi fosse una via breve
per assimilare i suoi tredici volumi.
In matematica non ci sono scorciatoie né uscite
dal retro, e ogni acquisizione è una conquista, che dà gioia e
appagamento, ma vuole in cambio metodo, dedizione, impegno, tensione verso un risultato.
"Si cerchi di trarre insegnamento dal fatto che in tutta la
trattazione ho cercato di far risultare come chiara e preziosa
constatazione la fallacia del meschino criterio del minimo sforzo
inteso nel senso del piccolo e particolare e gretto tornaconto
immediato" - scrive Bruno de Finetti, nella prefazione alla sua "Matematica logico
intuitiva" - "Ognuno che ha sementa semini, ognuno che ha forze si
prodighi, e ci saranno per tutte le abbondanti messi che non prosperano
dove il seme e il sudore sono lesinati attraverso il miope calcolo dei
malintesi egoismi".
La
matematica è passione, senza assilli di tornaconti immediati.
Per essere ammessi alla scuola pitagorica si dovevano sì consegnare
tutti i propri averi, ma agli espulsi - come Ippocrate di Chio, che aveva accettato del denaro in
cambio delle dimostrazioni - se ne rendevano il doppio, per indennizzarli alla buona di ciò che non erano stati capaci di acquisire in
conoscenza.
Quando Abdul Kasem, divenuto Gran Visir del Sultano, offrì un posto di potere al fraterno amico Omar
al-Khayyam, se lo vide rifiutare per ben altra richiesta: "il favore più
grande che tu possa farmi e mettermi in grado di continuare a studiare
matematica finché ne avrò bisogno".
All'allievo ansioso di
capire, non tanto la matematica, quanto i vantaggi che poteva averne,
Euclide rispose, rivolgendosi a uno schiavo: "dagli tre oboli, visto che
deve trarre assolutamente profitto da ciò che ha imparato".
Platone ne fece una questione di decoro della razza
umana: "è indegno del nome di uomo chi ignora il fatto che la diagonale
di un quadrato è incommensurabile con il suo lato"; e Titchmarsh
rincarò la dose, col piacere, e anzi il dovere, della conoscenza per la
conoscenza: "può essere assolutamente inutile il sapere che pi-greco è
irrazionale, ma se potessimo saperlo sarebbe intollerabile non saperlo".
"Non capisco come puoi
dedicare tanto tempo a quella roba. In fondo, a che serve la tua
matematica?”, è la domanda che Guedj - nel suo romanzo "Il teorema del pappagallo" - mette in bocca a una delle comparse della storia. "E l'amore,
mia cara, a che serve?", le risponde uno dei protagonisti.

La matematica è fatica, la matematica è passione, e a fronte di tutto ciò non sembra esserci nulla da ricavare, in senso materiale, quanto meno nell'immediato.
Perché allora così tante intelligenze - e lasciatemi dire le più raffinate intelligenze - vi dedicano tempo ed energie?
"Che cosa c'è nella matematica" - domanda Jerry P. King - "che spinge così tanti uomini e donne a lavorarci con il fervore dell'artista che ci si dedica incessantemente, e che allo stesso tempo la mantiene al di fuori dell'esperienza del resto della società intellettuale?"
La risposta - arrivati qui - è imboccata: si aspettano la bellezza e l'emozione che solo la bellezza può trasmettere, nel presupposto che il bello sia un valore
supremo, tra i più degni di essere perseguiti, capace di trascende le inclinazioni personali, perché - se non proprio invariante - sicuramente abbastanza stabile nel tempo e nello spazio, per quel minimo - che in matematica è piuttosto elevato - di educazione ricevuta.
"L'anima è
intimorita e rabbrividisce alla vista del bello" - scrive Platone, nel "Fedro" - "sentendo che in sé
stessa viene suscitato qualcosa che non le fu impartito dall'esterno
attraverso i sensi, ma che è sempre stato presente in lei nella ragione
profondamente inconscia".

Il principio rimane inalterato quando dalle vette della matematica pura, senza nessuna applicazione identificata a priori, ci si trasferisce alla pratica scientifica, istituzionalmente finalizzata alla comprensione della realtà circostante.
"Lo scienziato non studia la natura perché sia utile farlo" - scrive Henri Poincaré - "La
studia perché ne ricava piacere; e ne ricava piacere perché è bella. Se
la natura non fosse bella, non varrebbe la pena di sapere e la vita non
sarebbe degna di essere vissuta [...]. Intendo riferirmi a
quell'intima bellezza che deriva dall'ordine armonioso delle parti e che
può essere colta da un'intelligenza pura".
Poiché
l'oggetto primario della scienza è la rappresentazione delle regolarità osservabili in natura, e quindi le teorie
devono avere di necessità un valore estetico, al punto da poter dire che la misura del successo di una teoria
scientifica è una misura del suo valore estetico, una misura dell'estensione in cui ha introdotto armonia in quel che in
precedenza era percepito come un caos.
Il metodo scientifico trova così fondamento in un valore estetico: fatti empirici sprovvisti di leggi non presenterebbero
alcun interesse, e leggi sprovviste di teorie avrebbero al più
un'utilità pratica; ma ciò che ispira e guida lo scienziato - sin dal principio - sono manifestazioni dell'impulso estetico, cosicché il criterio estetico non è solo un mezzo per trovare delle
spiegazioni e giudicare la loro validità, ma è parte
integrante di ciò che intendiamo per "spiegazione".
E si dovrà allora convenire che nel suo tendere alla verità - verso spiegazioni sempre più complete della realtà percepibile - la scienza non può che approssimarsi alla massima bellezza, se necessario andando persino oltre la bruta osservazione.







Commenti
Posta un commento