C'ERANO UNA VOLTA BURRUS, CASPARY E "SETA"...
Parlare dei grandi collezionisti del passato e delle loro collezioni - della "Seta" (1999), di Burrus (1964) e Caspary (1957) per rimanere su un orizzonte visibile - suscita lo stesso imbarazzo nel commentare i classici della letteratura: da un lato si ostenta la consapevolezza di fronteggiare creazioni artistiche di valore immenso, dall'altro si avverte un malcelato disagio per l'oggettiva difficoltà nella loro fruizione.
Seriamente: cosa pensereste di questa pagina di narrativa, se non vi dicessi che proviene da "I miserabili" di Hugo?
Davvero questa è letteratura?
Perché - testo alla mano, analizzato riga per riga, parola per parola, senza timori reverenziali - sembra più l'annuncio di un'agenzia immobiliare che non la pagina di un romanzo.
Perché - testo alla mano, analizzato riga per riga, parola per parola, senza timori reverenziali - sembra più l'annuncio di un'agenzia immobiliare che non la pagina di un romanzo.
Possiamo sicuramente interessarci alla letteratura dell'800 - leggere opere scritte nell'800, da autori dell'800, secondo i canoni dell'800 - ma con altrettanta certezza non leggeremo mai opere scritte oggi - nel 2025 - con l’approccio e lo stile dell’800.
Perché a quel punto preferiremo gli originali - che sono pur sempre Hugo, Manzoni e compagnia bella - agli sconosciuti di oggi che li scimmiottano; perché una prosa anacronistica si può ancora digerire sapendo che era lo standard dell'epoca in cui fu realizzata, ma non la si accetterà mai su opere moderne, verso cui sono maturate tutt'altre aspettative e ben altre sensibilità; perché un lettore moderno tollera e consente nei "classici" delle soluzioni tecniche e stilistiche che rigetta in chi pensa di emularle oggi, protetto dalla loro nobile ascendenza.
Perché a quel punto preferiremo gli originali - che sono pur sempre Hugo, Manzoni e compagnia bella - agli sconosciuti di oggi che li scimmiottano; perché una prosa anacronistica si può ancora digerire sapendo che era lo standard dell'epoca in cui fu realizzata, ma non la si accetterà mai su opere moderne, verso cui sono maturate tutt'altre aspettative e ben altre sensibilità; perché un lettore moderno tollera e consente nei "classici" delle soluzioni tecniche e stilistiche che rigetta in chi pensa di emularle oggi, protetto dalla loro nobile ascendenza.

Estratto da "Insegnare a scrivere: una sfida d'autore", di Cristina De Santis
(postfazione al volume "Per scrivere bene imparate a nuotare", di Giuseppe Pontiggia).
Questo stralcio da un testo di critica mainstream - dove i "classici" si difendono per dovere d'ufficio - impone più d'una riflessione.
Le opere classiche non sono "frutto di spontaneità e divina ispirazione" (come pensano le anime belle) né tantomeno "perfette in ogni loro parte" (che è un modo gentile per denunciarne un brutto invecchiamento).
Bisogna perciò tenere "un atteggiamento attivo di fronte al testo letterario", che "va sì collocato nel suo tempo" - contestualizzato - ma poi riconsiderato "nella sua presenza attuale", con "lo scopo preciso" di "vagliare la tenuta dell'opera".
Qual è - in definitiva - il valore dei "classici"?
"Un classico" - ci dice Calvino - "è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire", è "ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l'attualità più incompatibile fa da padrona".
I classici sono quindi dei sopravvissuti:
hanno attraversato il tempo e sono arrivati a noi, zoppicanti, sporchi e malandati - la loro prosa, oggi, mostra tutti i segni del tempo - ma sono comunque arrivati, grazie ad alcuni loro messaggi universali che riecheggiano di continuo nel mondo, e rimangono di costante attualità, anche quando
la contingenza se ne discosta.
I classici sono un giacimento di suggestioni, di
stimoli e conoscenze (e incidentalmente anche di informazioni storiche
su un'epoca) con cui mantenere il cervello in uno stato
vigile,
fertile, costantemente pronto all’uso; ma non devono suscitare nessuna
soggezione psicologica, e non bisogna sentirsi dei blasfemi quando se ne rilevano debolezze di struttura, di impostazione, di stile.
Cosa imparare dal passato?
Ne parliamo ancora oggi - le ricordiamo, le citiamo, battezziamo ogni loro pezzo col nome del collezionista - perché preservano un tocco di universalità, perché vi sono temi su cui non hanno mai smesso di trasmettere insegnamenti, perché alcuni dei loro principî ispiratori sono sopravvissuti al tempo (sebbene il complesso delle modalità realizzative possa apparire demodé).
Nei classici filatelici - come nei loro omologhi letterari - persistono dei messaggi di fondo capaci di attirare l'attenzione "anche là dove l'attualità più incompatibile fa da padrona".
Burrus ci invita a riscoprire e valorizzare i significati genuini degli oggetti filatelici - la normale genesi dei francobolli e il loro uso postale, oggi da ravvivare col contesto storico, politico e sociale, per proiettarli nella più ampia dimensione culturale - ridimensionando gli accidenti dell'artigianato di produzione, quando creano delle grandi rarità filateliche, senza avere però un autentico significato, un valore comunicativo.
Caspary enfatizza la qualità degli oggetti filatelici, richiama la necessità di farne un punto fermo nel processo di selezione, se del caso a discapito della completeness dell'insieme (che andrebbe peraltro reinterpretata proprio in ragione del vincolo qualitativo sui pezzi): perché è la qualità che consente di sviluppare e affinare quel gusto personale di cui difettava Burrus e che si rivela cruciale per evitare la bizzarra e straniante coesistenza tra pezzi straordinari e altri modesti.
"Seta", nel confermare l'importanza della qualità, realizza un autentico excursus nel futuro, coglie con mirabile anticipo - seppur con qualche inevitabile fraintendimento - un aspetto oggi riconosciuto di grande rilevanza: la centralità del pedigree di un oggetto filatelico, un presupposto ineludibile per conferirgli quella dimensione antiquariale verso cui si sta orientando la filatelia del XXI secolo (e in cui riecheggiano le sue origini più nobili: "l'hobby dei Re").
"Seta", nel confermare l'importanza della qualità, realizza un autentico excursus nel futuro, coglie con mirabile anticipo - seppur con qualche inevitabile fraintendimento - un aspetto oggi riconosciuto di grande rilevanza: la centralità del pedigree di un oggetto filatelico, un presupposto ineludibile per conferirgli quella dimensione antiquariale verso cui si sta orientando la filatelia del XXI secolo (e in cui riecheggiano le sue origini più nobili: "l'hobby dei Re").
Sono messaggi - alti e generali - che non smettono mai di dire quel che hanno da dire: serve meditarli e lasciarli decantare, ritornarvi sopra a distanza di tempo, forti del lavoro autonomo compiuto sotto traccia dal cervello, per scoprirne ogni volta nuove sfumature su cui riavviare lo stesso processo, in una danza continua di riflessioni, consapevoli e inconsce, da cui non si smetterà mai di imparare.
E da questi messaggi restituiti dai classici della filatelia - dalla prospettiva che offrono ai collezionisti di oggi - si può azzardare una visione su quel che ci attende.
Quale futuro?
La discontinuità suggerisce di stilizzare l'impostazione di una collezione con due termini geometrici contrapposti: orizzontale e verticale.
.png)
Estratto da "Le gioie del collezionare", di J. Paul Getty.
Una collezione orizzontale - massimamente orizzontale, 100% orizzontale - dilata il suo perimetro nel tempo e nello spazio, accoglie oggetti filatelici provenienti da una moltitudine di Stati e di epoche, si espande senza discriminare tra sorgenti tematiche.
Una collezione verticale - massimamente verticale, 100% verticale - restringe il suo perimetro al minimo ammissibile (in linea di principio anche a un singolo francobollo) e si sviluppa carotandone tutte le possibili specificità, i dettagli, le varianti.
La Burrus e la Caspary sono esempi del passato di collezioni orizzontali; sicuramente lo era anche la von Ferrary, per risalire al trapassato remoto; e lo è stata pure la Provera, per rimanere al passato prossimo.
La Collezione Stella (sul 15 centesimi del Regno del Lombardo-Veneto) e la Collezione Manzoni (sul 5 bajocchi dello Stato Pontificio) sono esempi moderni di collezioni verticali, nel senso più stretto del termine.
Di là dei casi estremi - utili a fissare i cardini della scala - ciò che rileva sono le innumerevoli casistiche intermedie, le situazioni che possiamo definire oblique.
La "Seta", la "Pedemonte", "Scilla e Cariddi", e poi ancora "Naples" e "Castrovillari", sono tutte collezioni oblique, ciascuna con una sua inclinazione.
Quel che osserviamo - lungo la direzione tratteggiata - è una progressiva verticalizzazione dell'asse collezionistico: partiamo da due collezioni estese a tutti gli Antichi Stati inclusivi dei Governi Provvisori ("Seta" e "Pedemonte"); viriamo verso una collezione centrata su due dominî - Napoli e Sicilia - tra loro connessi da vincoli politici e dinastici ("Scilla e Cariddi"); focalizziamo l'attenzione su uno solo di quei dominî ("Naples") per zoomare infine su una singola officina ("Castrovillari").
E non è un caso se l'ordine di presentazione delle collezioni (di per sé convenzionale) coincide con la loro cronologia (col naturale ordine di successione temporale) perché negli anni si è appunto affermata - e va rafforzandosi - la tendenza a collezionare in senso verticale, a creare insiemi filatelici connotati da una crescente specializzazione intorno a un ben definito nucleo concettuale.
Va da sé che occorrono parecchie cautele interpretative, per non finire abbagliati dalla realtà più immediata (tutto ciò che proviene dalla realtà - scriveva Henri Poincaré - dalla realtà può essere smentito); bisogna cioè interrogarsi sui fondamenti teorici - ammesso ve ne siano - che possono confortare sulla tenuta della tendenza osservata.
Esiste una superiorità oggettiva dell'approccio (tendenzialmente) verticale su quello orizzontale?
E' possibile individuare un livello ottimale di obliquità?
E in che modo i classici sono d'aiuto, oggi, nel trovare la corretta inclinazione della propria collezione?
Sono queste le domande da smarcare per leggere correttamente l'evidenza, resistendo alla tentazione di affogare ogni cosa in qualunquismi del tipo "ognuno colleziona come vuole", "l'importante è divertirsi", "non ci sono regole", col solo effetto di lasciar campo libero a una voracità che andrebbe invece tenuta a freno (per evitare abbuffate, indigestioni, nausea e vomito) a favore di una buona educazione a un sano appetito.
Restiamo seri, se vogliamo dare un fondamento scientifico a ciò che in tanti, in troppi, considerano ancora come un passatempo bislacco e per di più fuori moda. Rimaniamo seri, fermi e costanti sui principî, e recupereremo anche in filatelia quella dimensione culturale universalmente riconosciuta al collezionismo, ma di cui noi filatelici possiamo vantare una posizione privilegiata, sin dalle origini.

Estratto da "Il Collezionista - Italia Filatelica", n. 10, Ottobre 1951.

Estratto da "Il Collezionista", marzo-maggio 2023.
Com'è dunque spiegabile - con quali argomenti, quali ragionamenti - la tendenza delle collezioni a verticalizzarsi?
Conviene muovere dagli esiti del processo evolutivo dell'atto del collezionare, dall'interpretazione del collezionismo (filatelico) come tentativo eroico di raccontare un storia attraverso degli oggetti (postali) perché è proprio "la collezione come narrazione" ad avere per corollario l'affermarsi di un approccio verticale.
"Tutte le scene devono essere collegate da un 'perché', non da un 'e poi' " - ammoniva Aline Brosh McKenna, la sceneggiatrice del film "Il diavolo veste Prada": se succede qualcosa adesso e poi ci ritroviamo dentro un'auto, in un parcheggio con una donna che ha appena visto pugnalare qualcuno, e poi nel 1977 con un topo che si aggira in un asilo, e poi c'è un vecchio che intona canti marinareschi in un frutteto infestato dai fantasmi... beh, forse il regista sta esagerando nel mettere alla prova la nostra tolleranza, non trovate?
Oggi fatichiamo a capire le Collezioni Burrus e Caspary, come pure la Provera, per quanto imponenti e spettacolari, e per molti versi la stessa "Seta", perché le percepiamo come sequenze serrate di singole gemme tenute assieme da una serie di "e poi", e gli "e poi" non piacciono al cervello, non sono il linguaggio parlato dalla nostra intelligenza.
Il valore (filatelico, emozionale) di una collezione non è nella semplice somma dei valori (economici) dei singoli pezzi; risiede piuttosto nelle loro liaison, nel fil rouge che li attraversa, in quel complesso di interrelazioni che trasmettono la sensazione di una realtà unitaria di cui sia agevole trovare la chiave di lettura; e limitare il perimetro collezionistico, restringere il campo d'azione, è il passo preliminare - ancorché parziale - per creare una struttura di nessi di causa-effetto riconoscibile al senso comune, dei buoni perché, per riprendere le parole di McKenna: serve sapere perché quell'oggetto e non un altro, perché proprio in quella pagina e non altrove, perché i pezzi si susseguono in un determinato ordine tra gli infiniti possibili, e se queste
risposte mancano, allora anche gli insiemi più belli diventano fragili.
Se ne trae una prima indicazione operativa sul livello di obliquità da conferire alla collezione: concentrarsi su oggetti postali di un singolo Stato (ad esempio il Granducato di Toscana) o al più riferiti a territori uniti da vincoli storici (Napoli e Sicilia) o geo-politici (Ducati di Modena e Parma) avendo chiaro che i Governi Provvisori rappresentano già uno Stato diverso (per cui, ad esempio, lo Stato Pontificio e le Romagne sono da considerarsi separati).
Restano possibili delle varianti (chi colleziona il Regno di Napoli, ad esempio, tende naturalmente ad accogliere anche la "Trinacria" e la "Crocetta", che tecnicamente sono francobolli d'occupazione) ma lo schema di base è chiaro, preciso: non andare oltre un singolo Stato, o una riunione di Stati che si possano considerare sotto un profilo unitario (per ragioni storiche, politiche, geografiche).
Una collezione generalista - in stile "Seta" - risulterebbe con ogni probabilità discosta dai parametri moderni, e d'altra parte non è immaginabile una nuova "Pedemonte", la cui immortalità è dovuta a una "eccezionale confluenza di talenti" - per dirlo con Alberto Bolaffi - virtualmente non replicabile.
Così come è sconsigliato creare una collezione di collezioni verticali - un insieme di collezioni sganciate tra loro, ognuna impostata in senso verticale - per quanto la scelta sembra essere invalsa nelle dichiarazioni di intenti di molti collezionisti.
Creare tante collezioni verticali non si scontra solo con un problema di denaro - che pure ha la sua rilevanza: se ne ha davvero così tanto per sviluppare più collezioni simultaneamente? - ma soprattutto con una questione di fatica mentale nel mantenere la concentrazione sull'obiettivo.
Il collezionista si è avvicinato nel tempo alla figura dell'artista - ha un progetto da realizzare, un'opera da creare, per esaltare la propria personalità e materializzare le sua cultura, con cui lasciare un segno riconoscibile del proprio passaggio in questo mondo - e se pure le sue risorse economiche non fossero soggette a vincoli, se pure avesse tutto il denaro sufficiente per giocare su più tavoli, le sue energie mentali resterebbero comunque limitate (non si può pensare a più d'un argomento alla volta e il tempo giornaliero non può eccedere le 24 ore).
Collezionare significa creare un mondo, ma non si potrà mai creare alcunché se non si è i primi a immergersi - cuore, testa e anima - in quella realtà a cui si ambisce a dare una forma.
Non si tratta semplicemente di studiare - un Antico Stato, un periodo storico, un'emissione o un regolamento postale - ma di focalizzarsi, di creare un'esposizione diffusa e variata negli stimoli a un determinato argomento, sino a trasformarne l'apprendimento in uno stile di vita, in un processo legato a doppio filo alla propria esistenza, ai propri interessi, alle attività quotidiane.
Bisogna oltrepassare la visione scolastica, per cui da un lato c'è l'argomento da studiare e dall'altro ci siamo noi che dobbiamo impararlo, per entrare nell'ordine di idee di assimilare col coinvolgimento di tutta la nostra persona, di rompere l'ideale parete di cristallo che ci separa da quel mondo di conoscenza, per immergercisi a fondo.
Serve un rapporto costante, vario e pratico con l'argomento (della collezione); ce ne si deve letteralmente circondare, esplorarlo in ogni possibile declinazione, utilizzarlo come strumento per fare molto altro, sino a trasformarlo in un'abitudine, perché si potrà dire di conoscerlo solo nella misura in cui esercita un'influenza così costante e pervasiva da faticare a immaginare la propria vita senza la sua presenza.
interamente dedicato alla Collezione "Al di qua del Faro - Napoli 1858-1863"
(i cui sviluppi - rispetto a quanto visibile qui - hanno giustificato uno spazio dedicato).
"Al di qua del Faro" è un buon caso di studio per dare concretezza all'argomentazione,
per far capire che si devono padroneggiare i principî, se non si vuol diventare schiavi delle regole.
La collezione mostra una marcata orizzontalità, a uno sguardo puramente filatelico:
accoglie esemplari del Regno di Napoli (inclusi i periodi della Dittatura e della Luogotenenza),
del Regno di Sicilia, delle Province Napoletane e del Regno di Sardegna,
con apparenti e poco comprensibili sproporzioni compositive.
Ma tutto si riequilibra, avendo presente che l'asse è storico, e non filatelico,
una "deviazione perfettamente ragionevole dalle vie battute", per dirlo con Richard Feynman:
la collezione è verticale rispetto agli eventi storici del periodo 1858-1863,
che vengono documentati attraverso gli oggetti filatelici,
selezionati in proporzione alle informazioni da trasmettere,
sotto il vincolo di economicità dello stile, proprio di ogni narrativa
(per cui ogni messaggio va veicolato col minor numero di elementi, i migliori).
Serve tenere il cervello accesso, quando si parla di verticalità e orizzontalità:
si tratterà sempre di mettere a sistema tutte le proprie conoscenze, senza negarle tra loro,
con lo scopo di conseguire un risultato più preciso grazie alla somma di molte informazioni diverse.
un approccio radicalmente diverso rispetto allo studio ordinario.
Cosa fa un collezionista di "Napoli", di regola?
Sa bene che vi sono dei testi fondamentali
- la monografia di Emilio Diena, il lavoro di Albeto Diena sugli "svolazzi",
le pubblicazioni di Vito Mancini, il volume di De Angelis e Pecchi,
i numerosi articoli sparpagliati sui vari numeri del "Vaccari Magazine" -
e si ritaglia degli spazi di tempo per studiarli (nei week-end, in vacanza, o quando può)
e una volta esaurito lo spazio, e finito il suo studio, si dedica ad altro, si separa dall'argomento.
Viene così a crearsi una cesura tra la propria vita, da un lato, e la collezione dall'altro:
ci si dedica alla collezione "non appena si può", "quando si può", "a volte di più, a volte meno".
Lo studio immersivo obbedisce a tutt'altri paradigmi:
non nega l'approccio classico ("prendi il libro e studia")
ma lo scioglie in uno stile di vita dove la collezione è sempre presente.
Per chi vive in una grande città - per dire - il tragitto casa-lavoro può richiedere più di un'ora,
ma quell'ora la si può trascorrere invariabilmente ascoltando dei podcast sul Risorgimento,
(e magari se ne sarà cosi presi da non accorgersi della solita calca, nella solita metro in ritardo).
Quando al banco del pane stanno servendo il numero 29, e tu sei il numero 54,
non sbuffi e non ti lagni, ma rimugini su come migliorare le pagine della collezione,
e - magia! - il cervello ti spedisce i risultati della sua elaborazione in background di tutti podcast,
fornendoti quelle idee e quelle intuizioni che non sarebbero mai arrivate per vie ordinarie.
E quando ti ritrovi in una discussione sulle perversioni sessuali di Berlusconi
- che incredibilmente sembrano non passare mai di moda -
tu racconti la storia della cugina di Cavour, la Contessa Virginia Oldoini,
e fai presente che anche Re Vittorio Emanuele era un gran mignottaro.
C'è da organizzare una gita fori porta per il ponte dell'8 dicembre?
Ottimo: e se andassimo alla Reggia di Caserta?
Siamo stati ovunque, in tanti posti oggettivamente "della minchia",
e mai in un luogo così bello e così vicino: è pazzesco, non trovate?
E poi sarebbe anche un omaggio a Re Ferdinando, o se preferite all'Italia,
perché forse tutto ebbe inizio in quel - maledetto o benedetto? - 8 dicembre 1859...
E che Reggia di Caserta sia, allora, e siccome vuoi far colpo sulla tua famiglia,
ti premuri di studiarla quanto basta per fare tu da guida turistica.
E funziona - accidenti se funziona - e molto più di quanto ti aspettassi:
perché mentre sei lì che racconti al meglio che puoi
- sfruttando anche le tue conoscenze collezionistiche -
ti si avvicina un signore con la sua famiglia per chiederti se sei un professionista,
se si può unire a te nella visita della Reggia, e quale sia il costo del servizio.
Tu sgrani gli occhi e fai spallucce, tra le risate generali di tua moglie e dei tuoi figli.
Eravate partiti in quattro, e ora vi ritrovate in otto (e - mi raccomando -"diamoci del tu").
Ma sai qual è il fatto davvero importante?
Che tua figlia - improvvisamente - si è liberata dal torpore della noia,
lo stesso torpore del figlio del signore che ti ha avvicinato.
E ora è scomparso in entrambi, chissà perché.
Sarà mica per le tue fenomenali capacità oratorie?
Mah, chissà! Forse sì, forse no, e più probabilmente no, ma che importa?
Conta solo che - ora - tutti si stanno divertendo da matti.
Si pranza insieme, ovviamente, e tra una forchettata di spaghetti e l'altra,
arriva l'inevitabile domanda: "ma tu come fai a sapere tutte queste cose?".
Abbozzi un sorriso, fai spallucce, e butti lì quasi per caso una mezza risposta:
"mah... non so: forse perché sin da ragazzino mi piacevano i francobolli antichi...".
E - mirabile a dirsi - sono gli altri a chiederti di parlare della tua collezione,
e con tanta più insistenza quanto più vuoi dissimulare il tuo coinvolgimento emotivo.
Il paesaggio scorre via veloce, sul treno che vi riporta a casa.
Tua figlia ha la testa piegata sul telefono e non la smette di scrivere:
sorrisi, facce buffe, smorfie, sospiri... chissà chi ci sarà mai dall'altro lato.
Tua moglie ti dice che dovresti aprire un canale YouTube,
e tuo figlio ci mette il carico da dodici: "Sì, papà, dovresti farlo: spaccheresti!"
Rispondi con sorriso, infili le cuffie, chiudi gli occhi, ti spalmi sul sedile
e fai partire la playlist di Mimmo Cavallo:
♫Tedeum Gaeta, lode al tuo onore
per cento giorni e cento giorni di dolore..
Tedeum Gaeta, ai figli tuoi
che resti inciso il tuo ricordo dentro noi...♬
per cento giorni e cento giorni di dolore..
Tedeum Gaeta, ai figli tuoi
che resti inciso il tuo ricordo dentro noi...♬

Cosa vuol dire mantenere un'esposizione costante all'argomento,
ma diffusa e variata negli stimoli?
Come e perché tutta la vita viene affogata nella collezione?
Lo studio tradizionale preserverà sempre la sua centralità,
- perché non c'è un'alternativa ad aprire un libro per imparare
e non si può pensare di immergersi "invece di" studiare in modo focalizzato -
ma va creato un contesto passivo su cui lo studio attivo possa dare il meglio di sé:
sbriciolare l'apprendimento, disseminarlo lungo la giornata, conferirgli una dimensione sociale,
per rafforzare e velocizzare lo studio tradizionale attraverso un rapporto costante con l'argomento,
con una varietà di abitudini, di collegamenti continui, e di continua messa in pratica.
E' lo stesso principio per cui, se si vuole imparare una lingua straniera,
si deve necessariamente studiarla nel paese dove rappresenta la lingua madre.
Perché, sì, nulla potrà sostituire l'apprendimento tradizionale sui banchi scolastici,
ma poi - finito lo studio focalizzato - ci si ritrova comunque circondati dalla lingua:
la tv, i cartelloni pubblicitari, i negozi, il brusio negli autobus... tutto è in lingua!
E non è solo un fatto di lingua in senso stretto, in senso proprio,
ma di tutto ciò che implicitamente si associa a quella lingua:
i tratti somatici di chi la parla e i loro usi e costumi,
lo stile architettonico della citta in cui la si parla e suo clima tipico,
e poi le banconote, il cibo, e tanto altro ancora:
tutto concorre a potenziare i risultati lo studio tradizionale.
E se tutto ciò vi sembra insopportabilmente faticoso, e alla lunga insostenibile,
vuol dire che quell'argomento - la lingua straniera, il collezionismo o quel che è -
non è la vostra passione, ma solo un hobby, un passatempo, un interesse fra tanti.
Perché una passione - per definizione - ti assorbe senza stancarti mai
(se non per esaurimento, quando ci sei rimasto immerso così a lungo
che la stanchezza fisica non ti permette più di godertela come vorresti).
E neanche a dire che la persona appassionata sia monomaniaca:
una passione può scoprirsi in simbiosi con un'altra
e ci si può immergere in una ritrovandosi immersi anche nell'altra,
come avviene ad esempio con il collezionismo e la scrittura.
E con una certa finezza di ragionamento si potrà andare ancora oltre,
per scoprire un ventaglio di argomenti utili alla passione originaria:
senza scadere in impossibili multitasking, senza cedere alla superficialità,
si potrà dare un seguito culturalmente evoluto al suggerimento di Mondolfo
di "partire dall'oggetto filatelico come da uno spunto per capire, per apprendere,
per saltare a campi ben diversi dalla filatelia, per arricchirsi dentro".
La propria passione, quindi, non fagocita tutto il resto,
ma richiede di ricondurre ad essa tutto il resto, in modo strutturato e coerente,
per arricchirla di sfumature, di dettagli, di intrecci, di spiegazioni sempre più profonde.
Ma la passione deve rimanere una e una sola, deve esserci cioè un solo polo attrattivo,
se non si vogliono dissipare energie fisiche e mentali, disperderle in mille rivoli,
perché - in definitiva - non ci si immerge mai nel mare, ma solo in un suo punto specifico.
Smarcato l'estremo inferiore (il livello minimo di obliquità, di per sé già alto) c'è da capire dove collocare l'estremo superiore (il livello massimo, oltre cui non conviene spingersi) e qui tornano utili gli insegnamenti dei classici filatelici.
Quanto più si verticalizza la collezione tanto più si dovrà schiacciare il pedale della specializzazione per portarla avanti, conferendo valore e significato a dettagli via via più spinti, in contrasto con l'indicazione della Burrus (di rimanere agganciati alla genesi del francobollo e al suo uso postale); pure, quanto più ci si specializza, tanto più ci si devono aspettare pesanti concessioni sulla qualità degli oggetti, in contrasto con l'indicazione della Caspary (di tenere alti gli standard); e la specializzazione - infine - entra presto in conflitto con la possibilità di avere pezzi dotati di pedigree - come suggerito dalla "Seta" - perché quanti più dettagli si aggiungono tanto più si restringe la cerchia degli interessati.
I classici filatelici diventano così delle spie d'allarme contro una verticalizzazione eccessiva; fanno da contrappeso a tutto ciò che può auto-sabotare il progetto collezionistico; proteggono dalle ingenuità che possono colpire anche i più esperti,
dalle infatuazioni passeggere sempre possibili per tutti, dagli impulsi
incontrollati tanto più pericolosi quanto più si presume di esserne
immuni; spingono a esplorare la propria creatività, per tirar fuori le idee migliori.
Perché la collezione è un'esperienza emotiva, si costruisce con la testa, prima ancora che con i francobolli, e l'avventura più fascinosa è un impasto tra la storia delle comunicazioni, l'analisi dei suoi oggetti sotto i profili tecnici, grafici, artistici e d'impiego, e l'uso strumentale dei fenomeni postali per illustrare e documentare gli argomenti di proprio interesse.


Dalla "Introduzione" al primo numero della rivista "La Posta Mondiale" (1873).


Dal "Saluto ai lettori" della Redazione
del primo numero della "Rivista Filatelica Internazionale" (1891).


Dalla prefazione a "I francbolli del Ducato di Modena e delle Province modenesi",
del Maestro Emilio Diena (anno 1897).


Dagli "Atti del 1° Congresso Filatelico Italiano", Napoli, 28-30 maggio 1910.


Dagli "Atti del XIII° Congresso Filatelico Italiano", Brescia, 22-28 maggio 1926.

Estratto da "Il Collezionista - Italia Filatelica", n. 12, 1957.

.png)
Estratto da "Il Collezionista - Italia Filatelica", n.26, 1 luglio 1967.


Premessa di Enzo Diena al volume "Classici senza miti", di Dino Platone e Maurizio Raybaudi.


Estratto dall'intervista di Umberto D'Arro a Renato Mondolfo,
pubblicata sul volumetto "Renato Mondolfo", di Poste Italiane,
edito in occasione della "Giornata della Filatelia 1995".
E' stato un conforto - a distanza dalla prima stesura del post - scoprire una parziale coincidenza di vedute con quel personaggio monumentale che è Franco Filanci (col quale peraltro non sono sempre in accordo, ma proprio per ciò l'allineamento di punti di vista acquista maggior valore).
"Abbiamo sottomano il passatempo più appassionante, intelligente,
vario, divertente, personalizzabile del mondo, e pare che non ce ne
rendiamo conto!" - è la prima annotazione di Filanci, dall'immancabile intonazione provocatoria.
Perché la comunicazione postale - genitrice della filatelia - ha in sé un potenziale culturale difficilmente riscontrabile altrove, che andrebbe protetto, valorizzato e diffuso, se lo si ha davvero a cuore, e non certo esposto al "fuoco amico".
E' sicuramente un fatto che il ruolo del francobollo sia legato al messaggio su carta, e che il messaggio su carta abbia subito
un crollo improvviso, dopo secoli di dominio incontrastato; ma voler
spingere il fatto oltre sé stesso, abbandonarsi alla più ingenua delle estrapolazioni - e per di più con inclinazioni auto-lesionistiche - non ha nulla a che fare con la realtà delle cose.
Dare una risposta esauriente alla domanda di cultura che scaturisce dalle nuove generazioni - per recuperare l'istanza testuale di Enzo Diena, del 1984 - è un impegno invariante nel tempo e nello spazio, che va oltre le contingenze, indipendente dal fatto che oggi, anno 2025, tutti noi - giovani e non - comunichiamo tramite e-mail e WhatsApp.
Solo gli stupidi e i depressi possono vedere la fine della filatelia nella fine del francobollo. I castelli non vi interessano più, solo perché più nessuno li abita? Le regge - di Caserta, di Versailles - hanno forse perso d'attrattiva perché non esistono più le case regnanti? Il Colosseo è privo di valore, perché non vi si tengono più i giochi per cui era stato ideato? E - per contro - avete forse notizia di collezionisti di scontrini fiscali, vista la loro presenza quotidiana nella nostra vita?
Nel collezionismo - in ogni collezionismo, non solo filatelico - c'è un amore per la storia che ne costituisce una base inamovibile, e che dalla dimensione storica degli oggetti può solo trarre maggiore solidità.
"Per diversi secoli il servizio postale ha rappresentato il mezzo di comunicazione per eccellenza, praticamente unico e incontrastato; e tale è rimasto a lungo anche dopo l'arrivo del telegrafo - poco adatto a messaggi che siano qualcosa di più d'una informazione - e del telefono, per oltre mezzo secolo rimasto fuori della portata dei più. E il francobollo, l'espressione più immediata e popolare del servizio postale, ne è diventato il simbolo, sostituendo il vecchio corno di posta, e caricandosi col tempo di valenze istituzionali e politiche, culturali e propagandistiche (talvolta palesi, talvolta più sottese e da decifrare), che ne hanno fatto un oggetto di enorme interesse storico e collezionistico, sia di per sé che nel più ampio contesto della storia postale".
I presupposti per un sano proselitismo ci sono tutti, purché la si smetta di rievocare i fantomatici "tempi d'oro" - che lo erano solo nel senso deleterio di permettere profitti tanto facili quanto evanescenti, la famigerata farina del diavolo che finisce in crusca - e si inizi a (re)indirizzare la filatelia sulla strada che le è propria, quella della cultura, di là dello specialismo erudito, della rarità fine a sé stessa, del valore commerciale.
"Anche
se ammantato dell'ammaliante qualifica di specializzazione - e in
effetti per molti collezionisti rappresenta un campo appassionante di
esercizio e approfondimento, per nulla da trascurare - l'esame degli
aspetti tecnici delle carte-valori, dei bolli e di tutto il resto ha
però proprio lo svantaggio di non interessare al di fuori della
ristretta cerchia dei già filatelisti. E possono essere rari quanto si
vuole, ma una coppia di francobolli non dentellata al centro, una ruota
sinistra alta o un fuori registro di 3 mm colpiscono la fantasia e
l'interesse del pubblico come un nonnulla travestito da niente".
Servono un'ampiezza di vedute e una profondità di respiro in grado di restituire tutta la complessità e il fascino dei fenomeni postali, della loro influenza sugli usi e i costumi della società, nella loro dimensione istituzionale così come nelle sue forme più aneddotiche e curiose, con l'obiettivo di lasciar intravedere l'ampio spettro di linee narrative, di possibilità collezionistiche entro cui ognuno potrà scegliere la propria.
"Approfondire la storia della posta, del francobollo, degli oggetti
postali, inquadrandola nel contesto sociale e politico, artistico e di
costume, di cui sovente è una perfetta espressione, può essere
un'attività non solo culturalmente e collezionisticamente gratificante,
ma anche appassionante e divertente [e] per questo può essere, a saperlo leggere, il più vivo, sfaccettato, incredibile, umano, appassionante dei romanzi".
E un progetto fattibile o una pura utopia?
E un progetto fattibile o una pura utopia?
La domanda, pur lecita, tradisce parecchia ingenuità.
Le cose sono ciò che noi decidiamo che siano. Dipende quindi da noi, solo da noi, dalle nostre capacità e prima ancora dalla volontà di mostrare quanto siano intriganti le storie intorno ai francobolli. Dipende dalla parte più autentica e profonda di noi, di cui la realtà delle cose osservabili non sarà altro che un'espressione nitida e fedele.
"Basta avere una chiara visione generale, che ci consenta di poter capire e apprezzare ciascuna delle migliaia di vedute particolari rappresentate da francobolli e bolli, interi postali e tariffe, lettere e moduli, ma anche indirizzi e testi delle corrispondenze, telegrammi e immagini, abitudini e oggetti in qualche modo legati alla posta e alla comunicazione umana. E per ottenere questa visione generale basta metterci un po' d'impegno, di passione, di personalità".

.png)



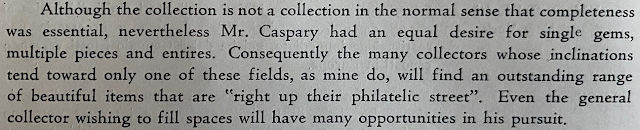










Commenti
Posta un commento